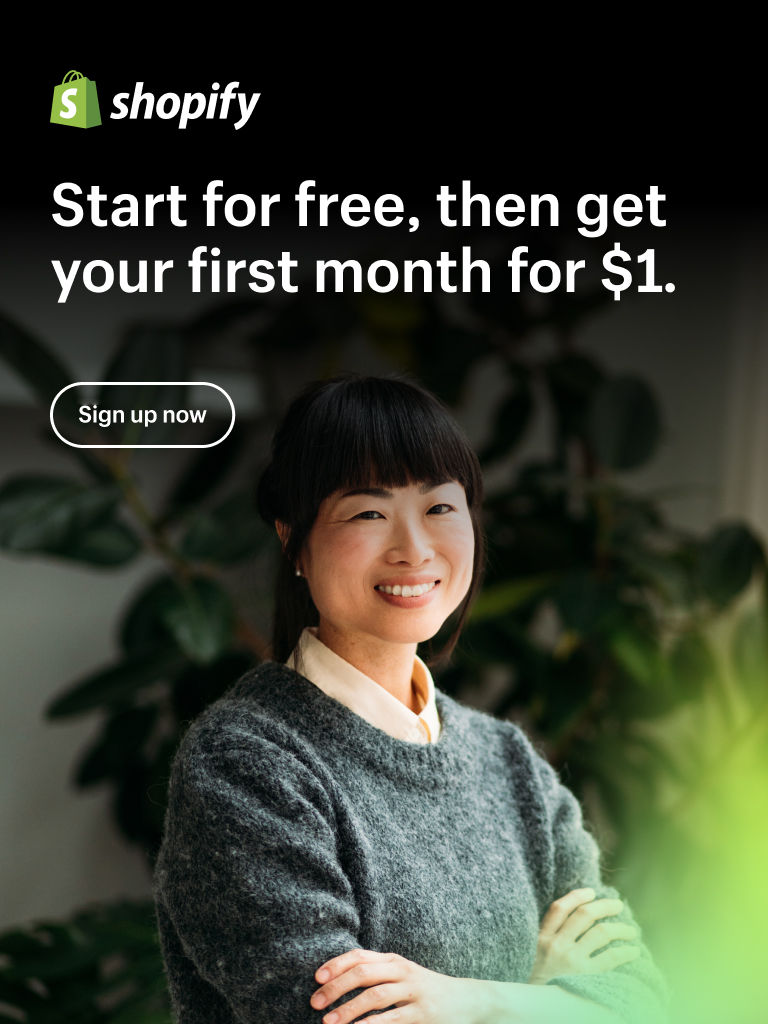Sfida fisiologica: ipossia in quota
L'ascesa ad altezze maggiori pone il nostro organismo di fronte ad una enorme sfida fisiologica. Con l'aumentare dell'altitudine la pressione barometrica e quindi anche la pressione parziale di ossigeno (pO2). Questa condizione è nota come ipossia - una mancanza di ossigeno nei tessuti. Per superare questa sfida, l'organismo attiva una complessa cascata di meccanismi di adattamento.

Fase acuta: reazione rapida dell'organismo
Nelle prime ore di permanenza in montagna, il corpo reagisce con immediati meccanismi di compensazione:
-
Iperventilazione: I chemorecettori dell'arco aortico e dell'arteria carotidea registrano la diminuzione della
pO2
e stimolano il centro respiratorio. centro respiratorio nel cervello. Questo porta a un aumento della frequenza e della profondità della respirazione per massimizzare l'assorbimento di ossigeno nei polmoni. - Risposta cardiaca: La gittata cardiaca aumenta aumentando la frequenza cardiaca per trasportare più velocemente l'ossigeno in circolo ai tessuti periferici.
- Spostamento di liquidi: L'organismo sposta l'acqua dalla zona intravascolare (plasma sanguigno) nello spazio spazio extravascolareche porta a una temporanea emoconcentrazione e aumenta la concentrazione relativa di eritrociti (globuli rossi).
Acclimatazione: adeguamenti strutturali a lungo termine
Dopo qualche giorno l'acclimatazione acclimatazioneuna profonda riorganizzazione fisiologica riorganizzazione fisiologica:
- Eritropoiesi: In risposta all'ipossia, i reni rilasciano una quantità maggiore di ormone eritropoietina (EPO) in risposta all'ipossia. Questo stimola ematopoiesi nel midollo osseo, che porta a un aumento della produzione di eritrociti cellule. Un aumento del valore dell'ematocrito e della concentrazione di emoglobina migliora la capacità di trasporto dell'ossigeno del sangue in modo significativo.
- Angiogenesi: Nel tessuto muscolare capillarizzazione - la formazione di nuovi capillari. Questo accorcia la distanza di diffusione dell'ossigeno tra i vasi sanguigni e i miociti. miociti (cellule muscolari).
- Livello cellulare: La densità dei mitocondrile "centrali elettriche" delle cellule, aumenta. Inoltre, l'efficienza di estrazione di ossigeno dal sangue, con conseguente ottimizzazione della produzione di energia aerobica. produzione di energia aerobica produzione di energia aerobica ottimizzata.
Queste regolazioni sono fondamentali per le prestazioni. Un'attenta strategia di acclimatazione riduce al minimo il rischio di mal di montagna acuto e consente all'organismo di sfruttare appieno i benefici fisiologici dell'acclimatazione all'altitudine.

Dormire in montagna: perché la rigenerazione notturna funziona in modo diverso a 2.000 metri di altitudine
L'influenza dell'altitudine sul sonno
Il sonno è una delle fasi di rigenerazione più importanti per gli alpinisti. Tuttavia, i modelli di sonno cambiano significativamente ad altitudini più elevate. L'ipossia porta a reazioni di risveglio più frequenti, a una riduzione della percentuale di sonno profondo e talvolta anche a una respirazione periodica durante la notte. Questi fattori possono compromettere in modo significativo il recupero fisico e mentale.

Strategie per dormire meglio nelle regioni alpine
Una buona igiene del sonno è quindi particolarmente importante: un'adeguata assunzione di liquidi, pasti e micronutrienti prima di dormire, un abbigliamento caldo sufficiente ed evitare alcol e caffeina. L'acclimatazione graduale riduce anche la probabilità di disturbi del sonno. Se ci si assicura di dormire a sufficienza e di alta qualità, si creano le basi per una migliore rigenerazione, un sistema immunitario forte e prestazioni durature in montagna.
Autore: Laura Bahmann
Fonti:
- West, J. B. (2012). Medicina e fisiologia d'alta quota. Oxford University Press.
- Levine, B. D. e Stray-Gundersen, J. (1997). "Vivere ad alta quota allenandosi a bassa quota": effetto dell'acclimatazione all'altitudine con esposizione intermittente all'ipossia sull'allenamento e sulle prestazioni atletiche.. Journal of Applied Physiology, 83(1), 102-112.
- Pugh, L. G. C. E. (1962). Aspetti fisiologici e medici della spedizione scientifica e alpinistica himalayana del 1960-61.. British Medical Journal, 2(5318), 1362.